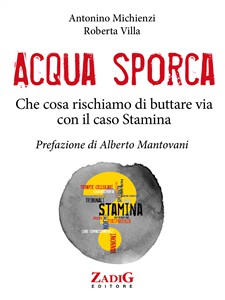Archivio Blog
Questo è un articolo che mi è stato commissionato da un giornale. Mi hanno anche gentilmente detto quando l’avrebbero pubblicato (dopo averlo ricevuto). Quel giorno però l’articolo non c’era, e da allora non rispondono alle mie mail… Bene, tanto per cominciare ho deciso di metterlo sul mio sito, silente da troppo tempo. Ma c’è un perché! Ho dovuto fare esami per 5 corsi, organizzando 10 prove scritte, e relative correzioni…per fortuna le mie Giulie sono state bravissime… e ora spero di riprendere anche il mio sito, considerando che il secondo semestre è libero da impegni di insegnamento.
Eccolo
Il nome-Teoria dei Giochi- potrebbe far pensare a una parte della matematica in cui i ricercatori sono persone leggere e forse anche sfaticate, che si occupano di problemi poco rilevanti. Nulla di più sbagliato! Bastano due semplicissime osservazioni per convincersene. La prima. Chi passa più tempo a giocare? I bambini che, tra l’altro, lo fanno molto seriamente: sono attenti, concentrati, e difficilmente qualcosa li può distrarre, nemmeno il bisogno di mangiare o andare in bagno (con qualche arrabbiatura conseguente dei genitori). La seconda. Tutti o quasi gli avvenimenti più importanti proposti dalla televisione, a livello mondiale, sono riproduzioni di giochi. Tra gli avvenimenti più seguiti al mondo in diretta ci sono manifestazioni sportive, giochi per eccellenza. Il motivo per cui i bambini giocano così tanto e gli adulti si appassionano allo sport è lo stesso: il gioco è una rappresentazione simbolica molto efficace di quella che è la vita di ogni giorno di tutti gli esseri viventi. I bambini giocano con lo scopo di allenarsi per essere meglio preparati per il gioco della vita, il più importante di tutti. Una partita di calcio ci attira perché rappresenta un simbolo tangibile delle lotte che affrontiamo ogni giorno quando ci alziamo dal letto. E dunque la Teoria dei Giochi è una parte della matematica molto seria, che studia problemi reali, e che può aiutare ad affrontarli meglio. Voglio in queste poche righe presentare alcune delle applicazioni più recenti della teoria, senza soffermarmi su quelle più naturali e classiche, che sono quelle economiche. Del resto per capire quanto essa sia importante per l’economia, basta ricordare il notevole numero di Premi Nobel assegnati a teorici dei giochi, compreso quello di quest’anno. Il primo esempio che vorrei illustrare riguarda un’applicazione alla medicina. In particolare, a un problema connesso col trapianto dei reni. Sempre più persone necessitano di un rene nuovo, che può cambiare radicalmente la qualità della vita di un malato (un paio di giocatori americani hanno vinto il titolo NBA, il famoso anello, dopo aver subito un trapianto di rene). Per questo motivo i reni prelevati da cadaveri non bastano, e sono destinati, anche se le donazioni aumentassero, a coprire una percentuale sempre minore di necessità. D’altra parte si vive bene anche con un rene solo, e quindi è possibile ricevere il rene da un donatore vivente. Ecco che così si formano potenziali coppie paziente-donatore. Il problema sorge però quando essi sono incompatibili: questo succede spesso, e dipende da motivi biologici. Diventa quindi naturale pensare a scambi tra donatori: le coppie paziente-donatore (A,B) e (C,D) potrebbero essere incompatibili, ma è possibile che (A,D) e (B,C) siano coppie compatibili. Perché dunque non organizzare uno scambio? E perché limitarsi a uno scambio tra coppie? Non potrebbe essere possibile e più efficiente organizzare scambi multipli? Credo non ci sia bisogno di dilungarsi a spiegare la quantità di problemi che sorgono per mettere in pratica queste procedure, che sono molto reali e concrete, visto che questi scambi avvengono da parecchi anni e che si è arrivati a farne che coinvolgevano sette coppie contemporaneamente… Su questi problemi il teorico dei giochi può dare contributi molto interessanti. Non solo per studiare il modo più efficace di organizzare gli scambi (questo vuol dire, per esempio, fare in modo che il numero più grande possibile di pazienti riceva un rene), ma anche per analizzare aspetti collaterali; ad esempio, in molte situazioni gli scambi massimali possibili possono essere più di uno. In questo caso allora è interessante individuare dei meccanismi di priorità che selezionino lo scambio più socialmente equo (questi scambi, di solito, privilegiano i pazienti con gruppo sanguigno 0, che sono coloro che hanno in assoluto meno donatori compatibili). Un altro aspetto rilevante riguarda quanto i sistemi di scambio possano indurre a mentire (ad esempio i pazienti e i loro medici) per ottenere vantaggi, e quali invece incentivano a dire la verità. Il premio Nobel dell’anno scorso è andato a due americani che hanno portato contributi fondamentali allo studio di queste meccanismi. Un’altra applicazione sorprendente riguarda un problema di genetica molecolare, con applicazioni mediche. Occorre una piccola premessa. Ci sono situazioni in cui è interessante capire quale è la forza relativa di un giocatore in un dato gioco. Un tipico esempio riguarda i partiti di un parlamento. E’ chiaro che un partito che ha più voti in genere si pensa che abbia più potere, ma è altrettanto chiaro che guardare alle percentuali può portare a valutazioni insensate. Può succedere che un partito con 4% sia cruciale in un parlamento (ad esempio se ci sono altri due partiti col 48%, che sono ideologicamente incompatibili), oppure del tutto irrilevante (se c’è già una maggioranza che non li comprende). La teoria dei giochi ha introdotto degli indici di potere per valutare la forza relativa dei giocatori in una determinata situazione. Con questi sono state fatte analisi per determinare quanti seggi assegnare alle singole nazioni nel parlamento europeo, o anche per stabilire se un azionista di una certa società non abbia in mano troppo potere, per cui in base a una legge potrebbe essere obbligato a cedere parte delle sue azioni. Uno dei pregi della matematica è di prendere oggetti che sono stati sviluppati per certi scopi, e rendersi conto che sono molto utili anche in contesti del tutto differenti. Ecco allora che si è pensato di applicare indici di potere per capire l’importanza di certi geni nell’insorgenza di malattie di tipo genetico. L’idea è di creare un modello di gioco in cui un gene più importante degli altri per lo sviluppo di una malattia sia un giocatore con grande potere. Il modello è stato fatto, e poi è stato applicato sia a casi di studio, sia a dati reali. In particolare abbiamo analizzato un certo tipo di tumore al colon-retto, malattia di cui si sa l’origine genetica, prendendo i dati dalle analisi di un certo numero di malati, e di persone sane, che servivano da riferimento. Questi dati sono disponibili in Internet, e sono anche in quantità enormi, quindi vanno trattati al computer. Abbiamo finalmente prodotto la “nostra” classifica dei geni. A questo punto siamo andati a controllare nella letteratura medica se erano segnalati dei geni come potenzialmente responsabili della malattia. Ne abbiamo trovato sette; di questi sei erano ai primissimi posti della nostra classifica, che ne comprendeva alcune migliaia! Quindi un risultato simile non può essere considerato casuale. La nostra idea è che i medici, con altre tecniche, potrebbero controllare se anche altri geni, ben classificati nella nostra lista, siano rilevanti nell’insorgenza della malattia: trovare al buio è molto più difficile che trovare sapendo quel che si cerca.
La vita e la scienza moderna sono molto complicate da analizzare. Occorrono molti esperti, in discipline differenti, per portare contributi significativi ad un problema complesso. Nel caso dei trapianti, c’è ovviamente bisogno dei chirurghi, di équipes medico-infermieristiche molto sofisticate, di manager, di matematici, di informatici, di bioetici e di filosofi, perché le tematiche coinvolte sono molteplici. Il teorico dei giochi è uno dei matematici che lavora maggiormente in équipe, e gli piace molto farlo.
Un recente articolo di Gianantonio Stella sul Corriere trattava di un problema che sta toccando le Università, e sono convinto che chiunque, o quasi, lo abbia letto, non possa che aver concordato con tutto quello che lui ha scritto. Del resto, credo che l’articolo di legge cui fa riferimento sia davvero uno dei pochi che ha ricevuto consensi a destra e a sinistra. Si tratta della regolamentazione delle “parentele” all’interno dell’Università. In particolare, la (facile) ironia dell’autore dell’articolo si concentrava su fatto che alcune Università hanno interpretato la legge in senso allargato, escludendo cioè la moglie dal rapporto parentale. In altre parole, la regola che si applica, ad esempio, tra padre e figlio, non si applica invece tra moglie e marito. Tutto l’articolo voleva convogliare sdegno su tale interpretazione, facendo l’ormai abusato esempio di un dipartimento di un Università, mi pare a Bari, dove sembra che in certi piani tutti gli studi abbiano la targhetta con lo stesso cognome (ma forse non sono tutti coniugi). Ora, come dico nel titolo, è evidente che il problema si pone. D’altra parte, questi fenomeni non succedono solo nelle Università, in un Paese in cui il familismo impera. Ad esempio, perfino forze politiche che si presentavano o si presentano come alternative non esitano poi a sistemare figli ovunque, che siano trote o consulenti informatici del movimento. Quindi il problema c’è. Ma per risolvere i problemi occorre un’analisi razionale e non emotiva. Allora, tanto per cominciare, a mettere i puntini sulle i va chiarito che è vero che il rapporto moglie-marito è sostanzialmente diverso da quello padre-figlio. In molti ambienti di lavoro ci si incontra, ci si conosce, e poi ci si sposa. Che questo debba diventare, persino retroattivamente, un macigno sulla carriera delle persone, mi sembra eccessivo. Ma il punto non è questo. Il punto è: una legge come questa risolve il problema del familismo all’Università? Certamente dà un segnale, questo lo riconosco. Ma penso che non risolva nulla, anzi che faccia danni. Il motivo è semplice. Le persone con mentalità mafiosa sul lavoro non si lasciano certo spaventare da questi provvedimenti. Per esempio, supponiamo che un Rettore di una grande Università di una grande città, che magari ha tre Università, sia dedito a sistemare moglie, figli e parentela varia nella sua Università. Credete che questo fantomatico Rettore si spaventerebbe per un provvedimento del genere? Certo che no. Le persone mafiose hanno tutta una serie di relazioni con persone della stessa risma, che magari stanno in Università contigue. Ecco quindi che uno scambio di favori risolve il problema. Al contrario, nei dipartimenti a pochissima o nulla densità mafiosa un provvedimento del genere i danni li fa, eccome. Da noi c’è chi vuol cambiare dipartimento, o chi addirittura ha deciso di divorziare (già perché poi si può diventare amanti e su questo la legge non ci può fare nulla). In altri Stati non sono certo incoraggiate queste commistioni, ma nemmeno proibite. Dove c’è convenienza, nessuno si scandalizza se in un dipartimento si trova una coppia di coniugi. Dove ero a Davis hanno assunto moglie e marito, con la certezza di fare un grande affare. Lui, persona di altissimo livello, da solo avrebbe potuto pretendere un’Università più prestigiosa. Che però non avrebbe dato un posto anche a lei. Lei a Davis non sarebbe stata considerata come singola, ma ad un’analisi attenta dava comunque garanzie di inserirsi bene in Dipartimento e di fare un più che onesto lavoro. Del resto, mica sono tutti geni quelli che lavorano all’Università…La conclusione del Dipartimento è stata che l’operazione, trasparente, avrebbe portato vantaggi a tutti.
Mi è capitato, e non una sola volta, di trovarmi in dipartimenti con coniugi, e queste situazioni qualche imbarazzo possono crearlo. Ma posso garantire che in un ambiente di lavoro corretto la cosa è tranquillamente gestibile.
In sostanza quindi, dove sta il punto? Il punto sta che, nel lavoro e forse non solo nel lavoro, pretendere di rendere le persone oneste a forza di leggi e di proibizioni abbastanza arbitrarie, non porta mai da nessuna parte. Emanare grida, si sa, non è difficile. Ma quel che occorre davvero fare, e che si fa nei Paesi seri, è di rendere non conveniente alla struttura tutta un uso personale di una sua parte. Detto in altre parole, se si premiano le strutture che lavorano bene e per il bene comune, e si affama quelle gestite come il casato di famiglia, le cose cambierebbero davvero. Non è facile, lo so. Ma sono i problemi a non essere facili, e prendere vie sbagliate è comunque sempre peggio di provare, con fatica, a fare le cose giuste. E purtroppo questo è solo un piccolo esempio dell’approccio sbagliato che il nostro Stato si ostina a portare avanti, con sempre maggior pervicacia, in situazioni come queste.
Oggi, giornata di sole, sembra difficile persino ricordare tutta la pioggia che è venuta giù in questi giorni a Milano e praticamente in tutto il Nord. Con tutto il corredo di danni e polemiche conseguenti. Però la Natura, oltre che violenta e vendicativa, sa essere anche particolarmente bella. Domenica mattina, quando finalmente il cielo ha lasciato intravvedere un po’ di sole, sono andato, come tanti del resto, a fare un giro a Parco Lambro. Difficile resistere alla voglia di fare qualche foto con il cellulare, anche se con le foto non ho nessuna abilità. Il risultato comunque sta in questa serie di immagini.
Nella prima si nota un cartello di divieto di sosta. Almeno per le auto direi che in questo caso è inutile.
Questo sotto è un campo di calcio. La foto non rende benissimo, ma le porte riflesse nell’acqua hanno davvero un gran fascino. La particolarità di questa foto è che rovesciandola ha un effetto curioso…
Ed ecco la stessa foto capovolta! Sembra un quadro dei macchiaioli.
Qui le acque sembrano tranquille
Qui invece si vede che la forza della corrente è impressionante
Un bel viale che di solito si percorre a piedi o di corsa…
Bene, alcune foto sembrano venute abbastanza bene, altre molto meno. Le piccole non sono ingrandite perché sarebbero venute troppo sfocate. Al pc le vedo benissimo, e questo è un mistero per me, come lo è che importandole vengano rovesciate e quindi che le debba ruotare. Ma invece di pensare a questo (mezzo vuoto), penso al fatto che bene o male sono riuscito a creare una nuova pagina con foto, impresa quasi titanica per me (mezzo pieno)
Sono molto affezionato al mio blog. Però non si direbbe… Da un bel po’ di tempo non ho messo su più nulla. Eppure qualche idea ogni tanto mi viene… Però come sempre l’anno nuovo, che da buon accademico, quindi singolare per definizione, per me parte a Settembre, ha portato una serie di impegni al limite dell’asfissia. Anzi, l’espressione come sempre è impropria. Dovrei dire più ancora del solito. Non sto a farne l’elenco, cosa sempre spiacevole perché somiglia a una lamentela, e davvero io non intendo proprio lamentarmi per quella cosa che rimane la grande passione della mia vita. Però gestisco tre corsi in tre città diverse, e un dottorato, che in questo momento conta più di 50 persone, il che davvero mi tiene piuttosto occupato… Si è aggiunta, negli ultimi tempi, tutta una serie di fastidi fisici piuttosto fastidiosi, che hanno origine dalla colonna vertebrale ma si divertono a spaziare anche in zone limitrofe. Per cui stare al computer è sconsigliato, almeno quando si esce dallo studio… Credo che mi stia succedendo esattamente quello che una volta mi ha detto una persona, conosciuta da pochissimo, ma che ha saputo inquadrarmi perfettamente, almeno in quest’aspetto: ho capito, sei uno di quelli la cui mente si rifiuta di ascoltare il fisico che suggerisce di cominciare a rallentare… Insomma, questo post è praticamente senza un vero senso. Ma l’ho voluto scrivere lo stesso, perché siccome ho la dimostrazione matematica che almeno una persona ogni tanto ci va a curiosare, ebbene non mi sto rivolgendo all’insieme vuoto se dichiaro che non ho intenzione di far morire d’inedia questo mio refugium che condivido con pochi (ma buonissimi).
Ieri (ho scritto questa nota qualche tempo fa, poi l’ho dimenticato causa preparativi per la partenza per le vacanze, ed oggi, altra giornata dal tempo deprimente, l’ho recuperato) finalmente sono finiti i mondiali di calcio. Ho visto un certo numero di partite: un tempo non ne perdevo neanche una, adesso invece se devo fare altro di una qualche importanza, perdo la partita, senza rimpianti. Ammetto che il calcio mi annoia sempre più, dal punto di vista logico lo trovo sempre meno attraente, da ultimo anche tutto quel che c’è attorno al calcio mi infastidisce sempre più. A cominciare dall’idiozia generale di commentatori e pubblico, ben peggiore, in genere, che negli altri sport. Figurarsi che oggi i giornali argentini se la prendevano con l’arbitro, forse hanno guardato solo lui, dimenticandosi che cosa hanno combinato Higuain e Messi, per esempio. Ma oggi non voglio parlare di calcio, e del lato deteriore dello sport vissuto passivamente, ma di qualcosa che invece dà lustro allo sport, al suo spettacolo e ai suoi significati. Parlo di basket, e più precisamente della serie finale per l’assegnazione dello scudetto italiano. Intanto, il basket è uno sport che ha risentito molto meno del calcio dell’enorme miglioramento atletico dei giocatori. Le partite continuano a essere belle, appassionanti, spettacolari. E questo già non è poco. Ma non è questo il punto più importante. Il basket è vissuto in maniera diversa, sul campo e sugli spalti (anche se i tifosi non sono aquile in nessuno sport, forse è proprio il concetto di tifo che corrompe la mente).
Dunque, un po’ di storia. Erano un sacco di anni, credo otto, che Siena vinceva a piene mani. L’impressione è che fosse una squadra forte, ogni tanto aiutata anche dall’esterno, e forse questo succede spesso, con le squadre forti. Di più. C’è in corso un inchiesta perché sembra che Siena si sia resa più forte ancora, violando le regole in maniera pesantissima. In particolare, pagando profumatamente, in nero e all’estero, un bel po’ di giocatori. Non basta, chi ha organizzato tutto questo è anche accusato di aver fatto creste e crestone su queste operazioni, per arricchimento puramente personale. C’è quindi il rischio che questi scudetti possano essere cancellati con un tratti di penna, o meglio con una sentenza di un qualche tribunale sportivo. E che il suo dirigente principale finisca pure in galera. Ma c’è di più. La società basket, forse risentendo di tutte le peripezie della Banca Montepaschi, è fallita. Il suo campionato si è concluso con un manipolo di giocatori stranieri che già sapevano che la loro esperienza a Siena era conclusa, con qualche italiano a fine carriera, con un allenatore che sapeva di allenare una squadra che stava per sparire, e di farlo per un anno solo. Di fronte a Siena la EA7 Milano, squadra destinata (speriamo con altra etica) a prendere il posto di Siena come corazzata del campionato, in virtù di un proprietario di enormi risorse finanziarie, e con dietro una città come Milano che, almeno se le cose vanno, riempie i palazzetti come nemmeno gli stadi di calcio di molte squadre di Serie A. Insomma Milano a confronto di Cantù, Armani a confronto dei Cremascoli … non esattamente le stesse potenzialità.
Ci si poteva aspettare una serie (nel basket vince il campionato la prima squadra che vince quattro incontri) già segnata in partenza. Ebbene non è stato così. Non tutte le partite sono state belle. In certi momenti si è assistito a una sagra di errori anche un po’ stucchevoli. Tecnicamente, gli amanti NBA avrebbero spesso potuto storcere il naso. Eppure, che serie! Basta ricordare l’inizio, 2 a 0 per Milano e conti chiusi secondo tanti. E invece Siena vince le sue due in casa, e poi sbanca Milano! Si arriva sul 3 a 2 con partita a Siena. In un certo senso l’ultima spiaggia per entrambe, con la differenza che una ha un futuro, l’altra no. Una partita incredibilmente avvincente, Milano sempre avanti, ma di poco, Siena che la raggiunge, e in un crescendo di tensione, si arriva agli ultimi secondi… Siena avanti di due punti, palla a Milano. Praticamente allo scadere Jarrell tira e insacca da tre! Si va a gara sette. Il Palazzo del basket di Siena è impressionante. I giocatori di Milano tutti attorno a Jarrell, quelli di Siena annichiliti. Il pubblico che applaude i suoi giocatori. Molti volti sono rigati di lacrime, e queste sono lacrime vere e da rispettare, perché Siena è stata un sogno per tanti anni, e quei volti sanno che il loro sogno è finito per sempre.
Però c’è gara sette da giocare, e anche questa è un vero, autentico, spettacolo di sport. Non importa se chi gioca sta giocando bene, non importa se si sbaglia troppo, importa che ci sono due squadre vere che si danno battaglia. Che vogliono prevalere, che accettano il combattimento, che si rispettano. Milano sempre in vantaggio, anche se non di molto, Siena che non molla mai. Si arriva all’inizio del quarto tempo, Siena è persino riuscita a mettere la testa avanti. Ma non basta, la squadra emergente ha qualche briciolo di energia in più, ha la forza del futuro, Siena cede quasi di schianto, il punteggio alla fine è persino punitivo per lei. Ma gli avversari per rispetto hanno giocato fino all’ultimo secondo.
La partita è finita. Milano fa festa, il parquet è invaso dai tifosi. L’allenatore di Milano è sorridente, in maniera composta. Il suo cuore non può godere pienamente del successo, comunque inseguito per una stagione. Lui era a Siena in tutti gli scudetti precedenti. L’immagine di chiusura è bellissima: un tifoso con maglietta Armani che si avvicina al capitano di Siena, Thomas Ress, e gli dà come una carezza di stima e di affetto. E lui che ringrazia con lo sguardo.
Tengo per una squadra povera. Ho sportivamente odiato Siena tutti questi anni. Ma ho voluto testimoniare il mio rispetto per la squadra di quest’anno, un team vero, un gruppo di persone unite attorno a un progetto, e che ha dato il meglio di sé fino all’ultimo, senza chiedersi neppure un attimo che cosa sarebbe stato domani.
Non si tratta dei soliti commenti su un romanzo finito di leggere da poco. No, stavolta parlo di un ebook (che se non ho capito male tale rimarrà, non sarà cioè pubblicato in versione cartacea) che va certamente letto da tutti coloro che hanno sentito parlare della vicenda qui raccontata. Parlo di Acqua sporca, scritto da Antonino Michienzi e Roberta Villa, per Zadig Editore. Il libro narra di Stamina, e di tutto (o quasi) quel che c’è dietro questa storia, per certi versi assurda, in qualche caso tragica, certamente complessa.
La prima cosa che mi preme sottolineare è che ho trovato molto apprezzabile lo stile con cui tutta la vicenda è narrata: una storia, una storia vera e documentata, ma una storia. Questo, secondo me, aiuta moltissimo chi vuol capire ma sarebbe forse un po’ timoroso di affrontare un libro di pura saggistica. Però sono altri i motivi che rendono questo libro molto prezioso. Della vicenda di Stamina ne abbiamo sentito parlare parecchio, a volte a proposito, molto più spesso a sproposito, ma molti aspetti della vicenda, secondo me, non erano noti ad un pubblico che, pur essendo interessato a queste tematiche, non è addentro alle vicende come un esperto. Ecco i punti salienti che il libro mi ha spiegato, e dei quali davvero sapevo poco o nulla.
Il primo punto fondamentale riguarda il perché tutto questo è successo e sta succedendo proprio nel settore nel quale si è mossa Stamina. In parole povere e brevissime (tanto dovreste leggere l’ebook) ho scoperto che dietro il problema delle staminali esiste una questione gigantesca e poco nota, almeno ai non addetti. Si tratta del fatto di stabilire se una terapia a base di infusione di staminali debba essere considerata come qualcosa di assimilabile all’assunzione di un farmaco, oppure no. La differenza è abissale, perché se si considera la procedura simile all’assunzione di un farmaco, allora i passi necessari per il riconoscimento della sua validità terapeutica (e quindi della sua possibile utilizzazione in condizioni accettabili) cambiano enormemente, perché richiedono passaggi lunghi, costosi, complicati, che l’assimilazione a un trapianto, ad esempio, comporterebbe solo in minima parte. Si può capire quindi gli interessi stramiliardari che decisioni in questo campo possono muovere, e di conseguenza tutte le guerre che si scatenano attorno a questioni come queste.
Ma non tutto si può ricondurre al denaro, nella vicenda di stamina. Quel che mi ha sorpreso è scoprire che un numero non trascurabile degli attori coinvolti nella faccenda avevano e hanno un interesse di salute personale legato al mondo delle staminali: lo stesso Vannoni ha sperimentato la cura su di sé, prima di lanciarsi nell’avventura di diventare lui stesso un operatore di staminali, quindi un dispensatore di cure, anche se tutto il libro dimostra che di cure non si può parlare in questo caso. La dimensione più umana (impressionante il racconto di come è partita la sperimentazione a Brescia, del perché possa aver attecchito lì l’idea di una cura totalmente al di fuori di ogni (ragionevole) protocollo) di tutta la faccenda mi era totalmente sconosciuta, e getta una luce un po’ diversa dalle motivazioni prime che uno può immaginare stiano dietro una faccenda come questa.
Mi sembra che il libro tocchi tutti gli aspetti salienti della vicenda, e li presenti con obbiettività e competenza. A un certo punto della lettura ho pensato che forse gli autori avevano tenuto la mano un po’ leggera rispetto a responsabilità abbastanza evidenti di persone, nonché organismi ed enti preposti alle decisioni. Però continuando mi sono reso conto che la prima impressione non era del tutto corretta, certe frasi qui e là a leggerle bene nascondono un (sacrosanto) giudizio piuttosto duro (una ricetta che si esprimesse così non troverebbe spazio nemmeno in un libro di pasticceria). Mi sarei aspettato, forse, qualche commento in più sulle responsabilità ministeriali e sulla ridda di sentenze che hanno accompagnato la vicenda, ma a posteriori credo che la scelta di non avventurarsi troppo in questo terreno minato sia stata molto ragionevole.
La conclusione per me è che questo libro ha avuto l’immenso pregio di farmi capire che dietro Stamina non c’è solo una vicenda assurda, senza senso, inspiegabile. Assurde semmai sono le Iene (e banditesche), con la loro disinformazione. Stamina ha dietro una faccenda complessa, che non nasce dal nulla, e il libro ne racconta la storia in maniera illuminante, perché fa capire, e lo fa benissimo, come tutto questo possa succedere.
L’ebook mi ha chiarito che dietro al problema dell’uso delle staminali, al di là dei ciarlatani, c’è il fatto reale che riconoscere una cura come farmacologica comporta burocrazia, attese, tempi lunghi, grandi quantità di denaro da investire; esiste quindi un problema reale, ed occorre lavorare continuamente per aggiornare le procedure; esiste un delicato equilibrio da trovare tra l’urgenza di chi soffre e la necessità di assicurare una cura certificata. Insomma, la tutela del malato è sempre al primo posto, il diritto a cure certificate è indispensabile, ma forse certe procedure vanno ripensate, anche in funzione dei problemi specifici che l’uso delle staminali sta ponendo. E che sono problemi reali.
E’ evidente che gli autori sono schierati, tra l’altro a favore dell’unica posizione possibile in un ambito che pur dovendo tenere conto di mille fattori, prima di tutto la disperazione della gente, necessita di un approccio scientifico ai problemi. Ma i loro commenti sono approntati a un grande equilibrio, e il loro sforzo di far capire che dietro questa vicenda non ci sono solo pazzi o banditi, ma problemi giganteschi, ha avuto a mio avviso pienamente successo.
Infine, come ho già detto, la storia è raccontata molto bene, il che non guasta mai.
Martedì scorso ad Alicante era la festa di San Juan, patrono della città. Niente di speciale, si potrebbe osservare, nello stesso giorno per esempio anche a Genova si festeggiava il patrono, San Giovanni, appunto. Eh no, non è la stessa cosa… Per fare capire perché, basta forse dare un’occhiata a queste foto, prese col mio Ipad.
Non chiedetemi che cosa voglia rappresentare questo oggetto un po’ stravagante: non lo so. Ha significati allegorici, che non conosco. Nella prossima già si riconosce qualcuno…
A volte, anzi il più delle volte, sono ironici, anche ferocemente:

Il re e la regina (ex, a essere precisi). Difficile credere che le zanne dell’elefante siano finite in quella posizione per caso…
Poi ci sono quelli che sicuramente piacciono ai bambini:
Mi rendo conto che le foto danno poco l’idea della dimensione di questi monumenti, alcuni dei quali sono davvero enormi. A proposito, chi si immagina di che materiale sono fatti? Io no di certo, ma so che si tratta comunque di materiale altamente infiammabile. Il motivo è molto semplice. Tutte queste costruzioni sono state incendiate la sera del 24! La festa consiste proprio in questo: avere i monumenti sparsi per la città il week end precedente, per poter andare in giro a osservarli, e poi divertirsi a vederli divorati dalle fiamme il giorno della festa. Tra l’altro, chi mi ha accompagnato nel giro notturno, mi ha assicurato che questi sono niente rispetto a quanto si può ammirare a Valencia…
In effetti ero arrivato sabato 14 Giugno a Alicante, e già quella sera, che ho passeggiato un poco in centro in attesa della mezzanotte (ora di Italia Inghilterra ai mondiali…) mi ero incuriosito non poco a vedere parecchie ragazze, e qualche signora, vestite in maniera evidentemente speciale, in particolare con gonne molto larghe, tipo queste (ma non proprio così, questi sono vestiti, lì mi ricordo soprattutto gonne)
Insomma, i preparativi per la festa, curiosamente per me, erano già in atto dieci giorni prima…
Tutto questo è interessante nota di colore, ma il soggiorno ad Alicante mi ha detto molto di più, e mi ha un po’ costretto a riflettere sul fatto che le loro abitudini sono abbastanza diverse dalle nostre, almeno se paragonate a Milano… Ovvia la considerazione che il clima, la presenza del mare, la dimensione della città pesano non poco sulle abitudini, sui modi di vivere, direi anche sulle relazioni sociali. Il clima, tipicamente del sud, aiuta le relazioni sociali spontanee, quelle leggere e genuine. Il motivo è semplice: si vive molto più spesso fuori casa che non in casa… ricordo una scena bellissima cui ho assistito casualmente a Messina: tornando in auto dall’Università verso il centro mi hanno fatto passare per un viale trafficatissimo che dava letteralmente sulla stretta spiaggia. A un certo punto ho notato con enorme sorpresa un tavolino sul marciapiede, e quattro signore probabilmente ultra ottantenni che tranquillamente bevevano il thè e giocavano a carte. Ma poi mi sono detto che la mia sorpresa non era giustificata, è naturale che in un clima così caldo e con un panorama così bello si stia sempre fuori, e fuori si incontrano tante persone. Questo ci dà abitudini e condiziona un po’ le nostre vite; è ad Alicante che ho ricordato e capito fino in fondo le parole di Resia, una collega di Napoli che ho incontrato a qualche congresso, e che un’auto assassina si è portata via un sabato mattina mentre andava in bicicletta per una strada di campagna. Una volta mi ha raccontato che quando non si sentiva bene, che quando la malinconia la prendeva forte, allora scendeva in mezzo alla gente per Napoli, e tutto le tristezze si allontanavano. Perché anche io l’ultima sera, passeggiando in una città strapiena di gente allegra e vociante, ho sentito allontanarsi malinconie e solitudini…
E poi il mare. Sono nato vicino al mare, ho vissuto accanto al mare per trent’anni, sono sempre andato al mare, sono stato anche un sub piuttosto bravo. La vita mi ha portate da un’altra parte, e sono convinto che dal punto di vista del mio lavoro essere venuto in zona Milano sia stata una grande fortuna. Ho bisogno di spazi, sono irrequieto, a Milano gravitano diverse Università, e questo mi ha dato parecchio, non foss’altro perché ho avuto poco tempo per annoiarmi. Pero tutto ha dei costi. Passeggiando di fronte a panorami come questo:
ho capito che forse la mia vita, il mio stesso carattere sarebbero stati un po’ diversi, persino il mio lavoro non sarebbe stato lo stesso. Perché finire alle sei di lavorare, prendere l’auto e tuffarsi con pinne e maschera in acque come queste, sarebbe stata una tentazione irresistibile, e poi perché mai si dovrebbe resistere a tentazioni come questa?
E’ stata una sola settimana di soggiorno in questa città, ma una settimana densa di sensazioni, pensieri, emozioni.
Muchas gracias, Alacant!
Oggi voglio parlare del fatto che a me sembra che il fanatismo, il totale disinteresse per provare a capire gli argomenti degli altri, il fatto di non accettare mai le decisioni della maggioranza non tanto nella convinzione di essere nel giusto, quanto nella certezza di star combattendo una guerra di religione, stiano dilagando sempre più, anche tra ambienti dove, uno si immagina, le persone dovrebbero essere portate a una maggiore riflessione. A volte mi chiedo se non sia, forse, più un modo di esprimersi che non una reale chiusura mentale: molte di queste forme di dogmatismo, almeno alcune di quelle che ho in testa, si esprimono con mezzi come Internet che tendono a farci esporre concetti con una semplificazione, e quindi con una radicalizzazione, estrema. Ma temo non sia così. Vorrei fare tre esempi, due dei quali solo accennati, solo perché mi hanno colpito, sull’altro invece mi dilungo un po’ di più, perché mi interessa più personalmente.
Faccio la breve premessa che oggi siamo sempre di più di fronte a problematiche complesse, che riguardano questioni spesso molto sofisticate, per cui è evidentemente difficile che una qualunque decisione presa porti solo vantaggi, sia valida per sempre, non necessiti continui adattamenti. Questo dovrebbe suggerire, secondo me, un atteggiamento più illuminato, più incline all’accettazione delle decisioni quando non ci trovano d’accordo, e non il contrario.
Il primo esempio è l’annosa questione della TAV. Intanto, mi sembra che dopo decine e decine di giudizi, appelli, processi, sentenze, una volta presa una decisione, questa non dovrebbe essere più messa in discussione. Capisco che in realtà la questione TAV è diventata per alcuni una buona ragione per sfogare istinti anarcoidi o antisistema, per altri per sfogare il loro mai spento pesudointellettualismo da strapazzo (e questi sono davvero i più odiosi di tutti), ma perché proprio la TAV è diventata un simbolo? Non capisco bene quel che è legato all’idea di trasporto. Ho fatto l’esperienza della galleria del monte Barro, anni e anni per farla, corsi e ricorsi, guerre di religione…ora che c’è la mia impressione è che il monte Barro sia molto più godibile di prima; le auto scorrono veloci dove un tempo si facevano code kilometriche con miasmi conseguenti, e non sto affatto dicendo che costruire una nuova strada, una nuova galleria, un nuovo ponte, un’altra strada siano SEMPRE buone idee (magari un giorno racconto il paradosso di Braess, un esempio famoso in teoria dei giochi dove si vede che fare una nuova strada può portare a un aumento dei tempi di percorrenza, inoltre è ovvio che nuovi mezzi di comunicazione incentivano uno spostarsi a volte poco sensato…), voglio solo dire che, come dovrebbe essere ovvio, si tratta di fare un bilancio onesto e senza pregiudizi tra vantaggi e svantaggi.
Il secondo esempio è relativo a una questione discussa su Facebook in questi giorni: una partita organizzata per beneficenza da una onlus che si occupa di una malattia molto rara che colpisce i bambini, è stata annullata per le minacce degli animalisti, che avevano minacciato azioni violente in quanto una delle squadre ha come sponsor una società che fa sperimentazione su animali. Ora questo a me sembra inaccettabile. La sperimentazione animale è un tema delicato, sul quale avere certezze dogmatiche è del tutto fuori luogo. Sono a favore di chi pretende rigorosi controlli, sono per chi combatte dure battaglie perché la sperimentazione animale sia sostituita da altro ogni volta che sia possibile, sarei felice se chiudessero quel lo zoo dove hanno ammazzato (in pubblico!) una giovane giraffa per questioni che mi interessano poco, però allo stesso tempo le persone che sono disposte a calpestare propri simili in difesa dei ratti da laboratorio mi fanno davvero intellettualmente paura. A me sembra che più che amore per gli animali questo sia odio per i propri simili (escluso qualche privilegiato). E credo che tutti quelli che non la pensano come questi fanatici dovrebbero ribellarsi di fronte a queste prepotenze.
E vengo alla questione che mi tocca più da vicino. Un po’ di tempo fa il Senato Accademico del Politecnico di Milano ha deciso che i corsi delle lauree magistrali sarebbero, da un certo momento in poi, stati erogati esclusivamente in lingua inglese. Come spesso succede, i vari passi della decisone sono passati senza apparente reazioni, ma quando si è arrivati alla decisione finale si è scatenata la bagarre. Si è anche arrivati a un ricorso al TAR (c’è sempre un TAR da qualche parte nella nostra vita…), che ha per il momento sospeso la decisione del Politecnico, con conseguente appello al Consiglio di Stato, che ovviamente ha chiesto supplementi di informazione: come è quella famosa? Mentre a Roma si discute, Sagunto brucia…Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur….
Vorrei chiarire la mia posizione personale su questo punto. Ancora una volta, vedo pregi e difetti in questa decisione. Aprirsi veramente agli studenti internazionali secondo me non è più nemmeno una scelta, è una necessità. Ho visto da tanti anni in Francia questo fenomeno, e in certi momenti alcune Università sono state salvate dalla presenza di studenti stranieri. E poi sono evidenti i vantaggi di formare persone specializzate da noi: spesso quando tornano nei loro paesi mantengono rapporti di lavoro con l’Italia. Tuttavia ho avuto qualche dubbio sulla decisione perché mi è parsa troppo radicale. Sono convinto che la scelta dell’Inglese sia naturale per certi corsi di studio, meno per altri, sono convinto che qualche percorso in Italiano avrebbe salvaguardato studenti un po’ timorosi di passare a studiare in una lingua straniera, anche se il loro numero è per fortuna in drastica diminuzione. Comunque la decisione è stata presa dopo tante discussioni, ed è evidente che si tratta di una scelta strategica che va valutata nel lungo periodo, il che tra l’altro inficia molte delle argomentazioni che ho sentito, sia favorevoli sia contrarie, basate su considerazioni che hanno senso solo sul periodo molto breve.
La maggioranza dell’Ateneo sembra aver accettato la decisione presa dai vertici, alcuni forse l’hanno subita ma accettata, poi c’è chi invece della lotta all’Inglese obbligatorio nelle Lauree Magistrali ne ha fatto una guerra di religione. Già a me le guerre non piacciono, quelle di religione ancora meno, quello che mi infastidisce enormemente in questa è il fatto che chi la porta avanti si è autoproclamato il difensore della lingua italiana. Io ritengo che assimilare i favorevoli alla decisione a quanti disprezzano o non vogliono difendere la lingua italiana sia francamente offensivo.
Sono colpito dal fatto che nella mente di queste persone non passi nemmeno un attimo l’idea che si possa avere una visione diversa delle cose: c’è chi come me pensa che le nozioni che eroghi a ragazzi di 22-24 siano ormai soprattutto avanzate, tecniche, non più così formative. Ho fatto un lavoretto per una banca, in un dipartimento dove lavora una mia ex-laureanda, e ci siamo trasmessi tutti i documenti in Inglese, perché così era più comodo. La formazione vera si fa prima… Ho letto articoli (ogni singolo articolo che (s)parlava della decisone del Politecnico ci veniva mandato nella lista docenti) scritti in un italiano vergognoso, questo sì che mi dà fastidio… sono pronto, se questi signori volessero fare davvero qualcosa di utile, a rumoreggiare e spernacchiare ogni volta che qualcuno, forse per apparire à la page, usa termini inglesi ridicoli. Detesto l’uso della parola “endorsement” e come questa cento altre che potrebbero essere tranquillamente tradotte ma così non fa figo…ecco su questo sono pronto a far battaglie. Come avrei apprezzato che quelli così contrari, una volta che la decisone è passata, avessero fatto una battaglia per organizzare all’interno dell’Ateneo delle attività di valorizzazione della lingua italiana; sono convinto che si sarebbero trovate un sacco di persone come me al loro fianco…ma forse una guerra ideologica fa più comodo.
La lingua si può difendere in mille modi, esistono tante iniziative possibili per salvaguardare l’italiano. Mi piacerebbe parlare in Ateneo di che cosa possiamo fare, con la presenza di tanti studenti stranieri, per diffondere anche la nostra lingua. E queste iniziative potrebbero coinvolgere, ovviamente, anche gli studenti italiani. Così si fa un servizio alla lingua italiana e alla comunità alla quale si appartiene, anche quando vengono prese decisioni che non ci trovano d’accordo.
Amo la lingua italiana. Quest’anno ho tenuto un corso di teoria dei giochi e uno di game theory: sono sostanzialmente indifferente sulla lingua che uso (ammetto che in matematica questo è molto più facile che in altre discipline, comunque). Non mi importa nulla che l’anno prossimo saranno entrambi in Inglese, mi importa lavorare in un ambiente che cerca di essere eccellente, che vuole crescere, e dove tutti remano nella stessa direzione.
Il 10 Marzo ho fatto una conferenza a Palazzo Ducale, la prima di un ciclo organizzato da Giovanni Filocamo e dal titolo Non solo numeri, con bellissimo sottotitolo Matematica a Palazzo. Per chi fosse interessato, ecco il link al programma…
http://www.palazzoducale.genova.it/naviga.asp?pagina=87050
Di solito metto le mie presentazioni nelle sezioni di scienza o di divulgazione, ma questa volta ho deciso di metterla in un articolo nella home. Il perché è molto semplice. Una conferenza a Genova per me ha sempre un sapore diverso, figuriamoci poi se la conferenza è ospitata a Palazzo Ducale! Perché è così diversa, al di la della semplice considerazione che sono genovese? Intanto, tornare nella propria città d’origine non è esattamente un’emozione qualunque. Le origini contano, eccome. Mi ricordo benissimo ancora adesso la sensazione di quando, venticinque anni fa, sono tornato dalla California, dove speravo di restare almeno un anno in più. Nei momenti in cui non era chiaro se sarei potuto rimanere, pensavo con forza che se fossi tornato allora mi sarebbe piaciuto tornare a Genova. In realtà, quando sono tornato, ben lungi da me la sola ipotesi di trasferirmi di nuovo in Liguria, anche se avessi potuto! Questo per dire che so che a volte ci culliamo in sensazioni e pensieri che non reggono alla prova dei fatti: per me il lavoro è molto importante e non avevo dubbi allora, una volta tornato, dove volevo stare…però Genova era nel cuore, lo è ancora oggi, anzi oggi più di allora; tornare in città non significa solo incontrare i parenti e gli affetti, rivedere qualche persona che non vedevo da tempo, incontrare uno dei figli (che sono felicissimo abbia fatto il mio percorso inverso…), significa fare dei dolci conti con quello che ero più di trent’anni fa.
Lunedì dunque il mio appuntamento con Palazzo Ducale è stato emotivamente importante. Tra le altre cose, vorrei ringraziare Giovanni Filocamo, non solo per avere pensato a me come a uno degli oratori della sua serie di conferenze, ma anche di avermi chiesto di essere quello che avrebbe aperto il ciclo…l’ho sentito un onore tale che non ho avuto dubbi a rinviare di un paio di giorni la mia partenza per Parigi, città d’elezione degli ultimissimi tempi (ha in effetti rubato un po’ il posto a Barcellona, insomma in questo periodo meglio Ibra di Messi!).
Una conferenza come quella di Palazzo Ducale, pur essendo ormai avvezzo a parlare in pubblico, e sapendo che di solito lo so fare abbastanza bene, è sempre molto difficile da immaginare. Oramai parlare a un congresso per me è un’abitudine. Certo, prima di cominciare c’è un po’ di tensione, a volte ho paura di parlare di cose poco interessanti, ma in fondo il compito non è difficile: più il tema è ristretto, più il pubblico è specializzato, più le cose sono semplici. E poi, sinceramente, i matematici molto spesso sono dei disastri a parlare, certo io sono più di quelli che si ascoltano volentieri, quindi in genere sono abbastanza tranquillo: tra chi mi ascolta sicuramente ci saranno alcuni che pensano stia raccontando stupidaggini, ma sono convinto che pensino anche che non è così spiacevole ascoltarmi (e poi le tecniche per far finta di ascoltare e fare altro sono collaudate tra noi). Una conferenza a un pubblico eterogeneo è molto più difficile… chi avrei trovato a Palazzo Ducale? Che taglio avrei dovuto dare al mio intervento? C’è sempre il rischio di dividere l’uditorio in due parti: che pensa che stai dicendo banalità e chi invece pensa di non star capendo nulla…
Questo succede dappertutto, mica solo a Palazzo Ducale! Però a Palazzo ti viene incontro una persona, e tu, agitatissimo perché ti hanno chiamato a casa per dirti di arrivare prima che c’è RAI EDU che registra e vuole intervistarti, e questo naturalmente manda a pallino la tempistica, dicevo tu ti dici ‘quella persona lì so benissimo che la conosco, ma sto per fare una pessima figura perché non ricordo chi è’, per poi scoprire dopo un secondo che è Marco, un tuo compagno di scuola che non vedi da 15 anni, e che 15 anni fa hai visto una volta alla cena dei trent’anni della maturità, dopo trent’anni appunto che non vedevi più… però Marco era una presenza forte in quei giorni, e tante cose si riaffacciano alla mente…
Oppure gli zii e la mamma, che non mancano mai a uno di questi appuntamenti, e certo loro vengono per amore, e capisci una volta di più che quello che ha radici negli affetti dell’infanzia poi rimane per sempre. O gli amici di tua sorella, che chissà se vengono per salutarti, o per fare piacere a lei, che organizza sempre cene piacevolissime, cui invita anche i sampdoriani, tanto per dire…o qualche cugino di mia madre, esempio di un attaccamento incredibile alla nostra famiglia, per loro così importante.
Poi Giovanni mi presenta, e allora tutto svanisce: ci sono più solo io, insieme con la mia passione per quel che racconto, e che non mi stancherò mai di raccontare, purché ci sia almeno una persona che ha voglia di sentire quelle cose bellissime che ho imparato negli anni passati a fare l’unico mestiere che avrei potuto fare, perché sono nato per quello.
Ho recentemente letto su Facebook l’intervento di un professore di scuola che emanava un grido di dolore per l’obbligo che ha l’insegnante di dover giudicare con un voto i propri alunni. Come spesso succede su Facebook i commenti erano tutti di plauso per il post e per il grido di dolore. Con una eccezione, il mio post, in cui chiedevo se ero solo io a dissentire, oppure se ero l’unico a dirlo. Sono molto maldestro nell’utilizzare il computer, e ancor più Facebook, ma il fatto che poi il mio commento dopo un po’ non comparisse (non ho controllato se subito c’era) mi ha fatto sospettare davvero una forma di censura più che l’ennesimo pasticcio. Questo mi ha fatto arrabbiare e venire la voglia di scrivere qualche mia idea su questa storia dei voti, e cercherò di essere il meno acido possibile. Eh sì perché di questo buonismo, francamente melenso a essere gentili, o alquanto sospetto a pensare male, non se ne può proprio più. Gli argomenti della professoressa, angosciata di dover etichettare con un voto i suoi alunni, erano quelli che si possono immaginare. Prima di tutto il fatto che il voto genera ansia, in chi lo deve dare e in chi lo riceve, e poi che crea situazioni di competitività, invidie e gelosie, l’ossessione del confronto, ecc ecc. Ora io vorrei chiarire che la mania di quantificare tutto, di assegnare un numero a tutto ciò che si dice e si fa, a me proprio non piace. Ci vuole ragionevolezza. Ma credo anche che, fino a prova contraria, si vada a scuola per imparare il sapere e per attrezzarsi ad affrontare la vita. Non è l’unica istituzione a dover fare questo, ma ha un suo ruolo importante.
La vita non è la pubblicità del Mulino Bianco. Nella vita dobbiamo tutti affrontare giudizi, dobbiamo confrontarci con gli altri, siamo messi in classifica, siamo giudicati e dobbiamo giudicare. Nella vita ci potrà capitare di dover prendere decisioni drammatiche, o di essere oggetto di decisioni drammatiche. Sia ben chiaro, non voglio sostenere che siccome la vita è dura allora occorre fin da subito cazziare i ragazzini per far sì che siano ben attrezzati. Chi mi conosce sa benissimo che non sono così, che cerco di evitare attriti e competizioni ogni volta che mi sembra possibile, che sono molto competitivo solo in un campo da tennis, che mi sono scelto un lavoro in cui si compete più con se stessi che con gli altri (anche se la carriera accademica per certi versi competitiva lo è). Però credo che sia dovere preciso di un insegnante anche saper indirizzare e giudicare i propri alunni, premiare chi merita e richiamare chi non lo merita. Credo che sia importante saper anche, in certe circostanze almeno, classificare le persone secondo i loro meriti. Cercando di sdrammatizzare eventualmente le situazioni quando possibile: recentemente per esempio dopo un esame con 80 persone ho detto che non potevo essere certo che tutti i 28 fossero un po’ meno bravi di tutti i 29 i quali, a loro volta, forse non erano un po’ peggio di qualche 30. Ma ho aggiunto che questi voti sono comunque ottimi, che ognuno di noi, se appena è sincero con se stesso, sa che una volta è stato valutato un po’ stretto ma un’altra ha avuto un voto generoso…
Insomma valutare, dare voti, è un obbligo per noi, che va assolto con serenità, ed un diritto per gli alunni. Il problema poi mica si ferma alla scuola, proprio no. Questo egoistico buonismo a me sembra molto diffuso anche tra i genitori, che troppo spesso non hanno il coraggio di educare con energia, che trovano più comodo andare a scuola a protestare per un voto dato al figlio, a giustificare ogni loro comportamento, a chiedere comprensione per le difficoltà che si trovano ad affrontare, e che scoprono più gratificante allevare adolescenti che non crescono mai, perché non si sentono mai dire di no, piuttosto che attrezzarli già da giovani a prendere qualche responsabilità, e a confrontarsi con insuccessi e, a volte, pure con qualche ingiustizia.
Tanto è la vita a essere ingiusta. Con coloro ai quali voglio bene, cerco di essere presente e comprensivo nei momenti di difficoltà, ma mettendo in evidenza il fatto che, a volte, occorre accettare anche cose che non ci piacciono, o accettare una sconfitta anche se pensiamo di non averla meritata.